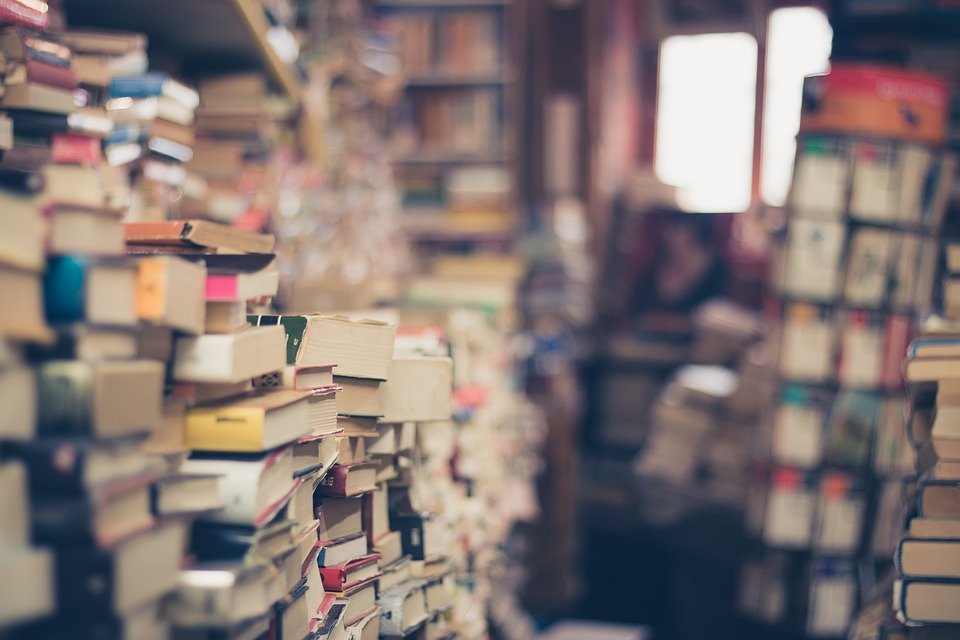Nel silenzio mattutino delle Alpi Marittime, quando la nebbia ancora avvolge i picchi innevati e le prime luci dell’alba dipingono d’oro i pendii rocciosi, si sente in lontananza il fischio di un treno. Non è un suono comune in questi luoghi dove la natura regna sovrana, ma è il richiamo di una delle ferrovie più spettacolari d’Europa: la Ferrovia delle Meraviglie che collega Cuneo a Ventimiglia attraversando un lembo di territorio francese.
Questa linea ferroviaria internazionale rappresenta uno dei più audaci capolavori dell’ingegneria civile mai realizzati sul continente europeo. In appena 96 chilometri di estensione lineare, che diventano meno di 50 in linea d’aria, la ferrovia supera un dislivello impressionante di mille metri, attraversando paesaggi che cambiano dalla pianura piemontese alle valli alpine, fino a raggiungere la costa mediterranea.
Un sogno risorgimentale divenuto realtà
La genesi della Ferrovia delle Meraviglie affonda le radici nel vision politico di Camillo Benso Conte di Cavour, che a metà dell’Ottocento immaginava un collegamento diretto tra il Piemonte e Nizza, allora sotto il dominio sabaudo. Gli studi si protrassero dal 1856 fino al 1895, con il primo progetto che venne vanificato dalla cessione di Nizza alla Francia nel 1860, evento che trasformò quella che doveva essere una ferrovia nazionale in un’ambiziosa impresa internazionale.
Il progetto definitivo prese forma solo all’inizio del Novecento, quando secondo un nuovo tracciato biforcuto, a Breil il ramo francese si sarebbe staccato in direzione Nizza, mentre il ramo italiano avrebbe proseguito verso Ventimiglia. La costruzione iniziò nel 1882, ma le difficoltà tecniche straordinarie e gli eventi storici del primo conflitto mondiale rallentarono significativamente i lavori.
Capolavori di pietra sospesi nel vuoto
Quello che rende unica la Ferrovia delle Meraviglie non sono solo i paesaggi mozzafiato che attraversa, ma soprattutto le soluzioni ingegneristiche rivoluzionarie che furono necessarie per domare un territorio apparentemente inespugnabile. La linea comprende 33 gallerie, molte delle quali elicoidali per superare le pendenze proibitive, e 27 ponti e viadotti che sembrano sfidare le leggi della fisica.
Sul fronte francese i lavori sono diretti dall’ingegnere Paul Séjourné, affermato costruttore di ponti ad arco e geniale autore dei quattro celebri viadotti di Scarassoui (1922), di Saorge (1922), del Caï (1927) e dell’Erbossiera (1928). Questi viadotti, vere e proprie sculture architettoniche in pietra, rappresentavano all’epoca l’avanguardia dell’ingegneria ferroviaria mondiale.
Le gallerie elicoidali costituiscono forse l’elemento più spettacolare dell’intera opera. Queste strutture, che permettono al treno di guadagnare quota descrivendo ampie spirali all’interno della montagna, furono una soluzione geniale per rispettare i limiti di pendenza imposti dai treni dell’epoca, pur mantenendo un tracciato tecnicamente fattibile.
Un percorso attraverso tre nazioni
Il viaggio sulla Ferrovia delle Meraviglie è un’esperienza che trascende il semplice trasporto. Partendo dalla stazione di Cuneo, il treno attraversa borghi piemontesi carichi di storia come Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante e Vernante, per poi inoltrarsi nel territorio di Limone Piemonte, ultima tappa italiana prima del confine.
L’ingresso in Francia segna l’inizio del tratto più spettacolare del percorso. Il treno attraversa i comuni francesi di Vievola, Tende e La Brigue, territori dove la cultura italiana e francese si fondono in un’identità unica. Qui la ferrovia serpeggia attraverso la Val Roya, una delle valli più selvagge e incontaminate delle Alpi Marittime, dove i boschi di larici e abeti si alternano a pascoli d’alta quota punteggiati da antichi borghi in pietra.
Il ritorno in territorio italiano avviene a San Dalmazzo di Tenda, per poi transitare nuovamente in Francia attraverso località pittoresche come Fontan-Saorge e Breil-sur-Roya, prima di raggiungere definitivamente l’Italia con le stazioni di Olivetta San Michele, Airole, Bevera e infine Ventimiglia. Da qui, la linea si connette con la ferrovia costiera francese che raggiunge Nizza, completando un tracciato che unisce montagna e mare in un abbraccio di acciaio e pietra.
Distruzione e rinascita
La storia della Ferrovia delle Meraviglie è segnata da una tragedia che ne ha condizionato profondamente il destino. Nel 1943, durante la ritirata, le truppe tedesche distrussero gran parte dei viadotti e delle infrastrutture, paralizzando completamente il traffico ferroviario. Questa devastazione sistematica cancellò in pochi giorni quello che era costato decenni di lavoro e ingenti investimenti.
La ricostruzione avvenne solo negli anni Settanta, grazie a un accordo italo-francese che portò alla realizzazione di nuove opere. Nel 1978 furono inaugurati i nuovi viadotti di Scarassoui e di Saorge, dove i grandi archi in muratura di Séjourné furono sostituiti da due ponti a cavalletto in calcestruzzo precompresso. Sebbene tecnicamente efficienti, queste strutture moderne non possedevano più il fascino architettonico delle opere originali.
Un viaggio nel tempo tra natura e tecnologia
Oggi, percorrere la Ferrovia delle Meraviglie significa intraprendere un viaggio che dura circa due ore da Cuneo a Nizza, ma che racchiude in sé secoli di storia, cultura e tradizioni. Durante la stagione turistica, guide specializzate accompagnano i passeggeri raccontando aneddoti e curiosità su questo patrimonio eccezionale che attraversa paesaggi che spaziano dalla costa mediterranea al Parco Nazionale del Mercantour.
L’esperienza di viaggio è resa ancora più suggestiva dalla varietà degli ecosistemi attraversati. Si parte dalla pianura padana con i suoi campi coltivati e le prime colline, per salire gradualmente verso le valli alpine dove la vegetazione mediterranea lascia spazio a boschi di castagno e faggio, fino a raggiungere le praterie d’alta quota dove crescono rare specie endemiche delle Alpi Marittime.
Il treno attraversa borghi medievali arroccati sui pendii, antichi ponti in pietra che scavalcano torrenti impetuosi, e gallerie scavate nella roccia viva dove il buio improvviso amplifica la sensazione di avventura. Ogni curva rivela panorami nuovi e inaspettati: pareti rocciose a strapiombo, vallate verdeggianti punteggiate da baite tradizionali, e scorci sul Mediterraneo che brillano all’orizzonte.
Sfide contemporanee e prospettive future
Nonostante la sua bellezza indiscussa e il riconoscimento come vincitrice del decimo censimento “I luoghi del Cuore” del FAI nel 2021, la Ferrovia delle Meraviglie affronta oggi sfide significative. L’alluvione del 2020 che ha colpito il Colle di Tenda e la Val Roya ha causato nuovi danni e interruzioni, rendendo necessari interventi di messa in sicurezza che si protrarranno per tutto il 2025.
Fino al 23 novembre sarà interrotto il tratto tra Drap e Breil-sur-Roya, mentre dal 24 novembre al 13 dicembre 2025 tutta la linea sarà completamente chiusa per tre settimane. Questi lavori, seppur necessari per garantire la sicurezza, testimoniano la costante battaglia che questa ferrovia deve combattere contro le forze della natura.
Tuttavia, l’impegno delle autorità italiane e francesi per preservare questo patrimonio è dimostrato dai continui investimenti in manutenzione e sicurezza. La riapertura del passo del Tenda, prevista per il 27 giugno 2025, segna un momento di svolta che potrebbe rilanciare definitivamente il turismo ferroviario in questa regione straordinaria.
Un patrimonio da scoprire e preservare
La Ferrovia delle Meraviglie rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto: è un monumento vivente all’ingegno umano, una testimonianza di come la determinazione e la tecnologia possano superare anche gli ostacoli apparentemente più insormontabili. Ogni viaggio su questa linea ferroviaria è un’immersione nella storia dell’ingegneria civile, un percorso attraverso paesaggi di rara bellezza e un ponte tra culture diverse.
In un’epoca in cui il turismo sostenibile assume sempre maggiore importanza, la Ferrovia delle Meraviglie offre un modello di viaggio rispettoso dell’ambiente, che permette di scoprire territori altrimenti difficilmente accessibili senza impattare negativamente su ecosistemi fragili. Il treno, infatti, consente di raggiungere località remote delle Alpi Marittime mantenendo un’impronta ecologica minima.
La conservazione di questa ferrovia storica non è solo una questione tecnica, ma una responsabilità culturale verso le future generazioni. Ogni galleria, ogni viadotto, ogni stazione racconta la storia di uomini che hanno dedicato la loro vita a un sogno apparentemente impossibile: unire con binari d’acciaio mondi diversi, creando un ponte fisico e simbolico tra Italia e Francia, tra passato e futuro.