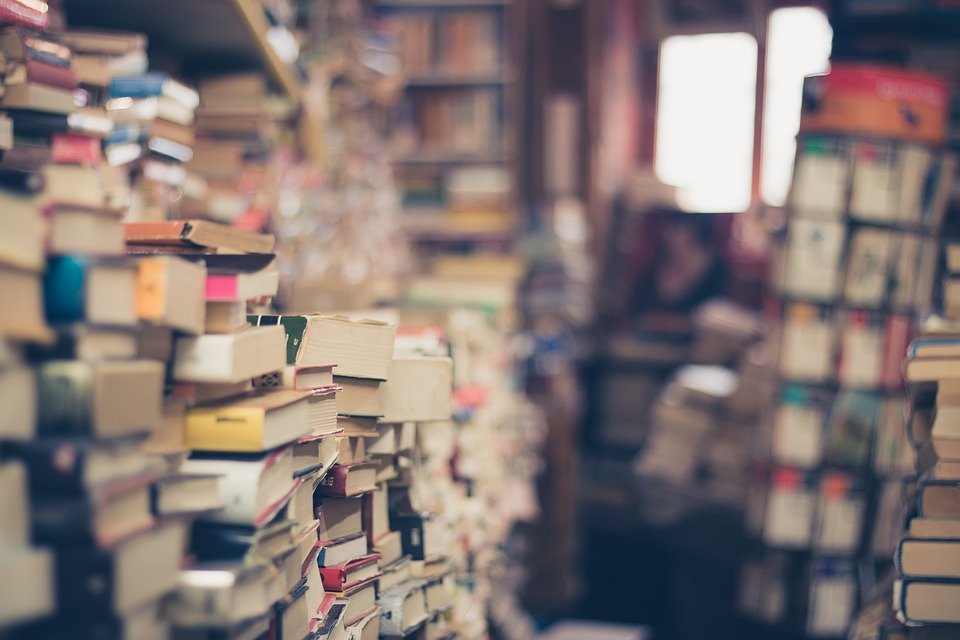L’Abruzzo nasconde tra i suoi monti e le sue vallate un patrimonio gastronomico ricco di sapori autentici e tradizioni millenarie. Oltre ai celebri arrosticini e agli spaghetti alla chitarra, questa regione dal carattere “forte e gentile” custodisce tesori culinari ancora poco noti al grande pubblico. Un viaggio gastronomico che conduce nelle cucine delle massaie più anziane, nei piccoli borghi montani e nelle osterie di paese, dove si tramandano ricette antiche che raccontano storie di resilienza contadina e ingegnosità culinaria.
La cucina abruzzese meno conosciuta è un mosaico di influenze che spaziano dalla tradizione pastorale delle montagne agli antichi sapori della costa adriatica. Ogni piatto racconta una storia fatta di ingredienti poveri trasformati in prelibatezze, di tecniche antiche tramandate oralmente e di una filosofia del recupero che non lasciava nulla al caso. Questi piatti dimenticati rappresentano l’anima più vera dell’Abruzzo gastronomico: genuina, semplice ma incredibilmente sapida.
Primi piatti dimenticati: quando la tradizione incontra l’innovazione
Sagne e fasciul: la pasta dell’ingeniosità contadina
Le sagne e fasciul rappresentano la versione abruzzese della pasta e fagioli, un primo piatto della cucina povera che sopperiva al fabbisogno proteico delle classi meno abbienti unendo legumi e cereali. Questa preparazione antica nasconde un’intelligenza nutrizionale straordinaria: l’assenza di uova nell’impasto della pasta fresca viene compensata dall’abbinamento perfetto tra carboidrati e proteine vegetali.
Le sagne sono strisce irregolari di pasta tirata a mano, dalla forma rustica e imperfetta che ne rivela l’origine casalinga. La preparazione inizia con una sfoglia di sola farina e acqua, lavorata energicamente fino ad ottenere un impasto elastico e omogeneo. I fagioli, rigorosamente cannellini locali, vengono lasciati in ammollo per una notte intera prima di essere cotti lentamente con sedano, carota e cipolla soffritti in olio extravergine d’oliva abruzzese.
Il segreto di questo piatto risiede nella cottura simultanea di pasta e legumi: le sagne vengono calate direttamente nel brodo di fagioli fumante, assorbendo tutti i sapori e rilasciando l’amido necessario per creare una consistenza cremosa e avvolgente. Il risultato finale è un piatto dal colore dorato, profumato di erbe selvatiche e peperoncino piccante abruzzese, che scalda il corpo e l’anima nelle fredde giornate montane.
Virtù teramane: il piatto delle sette virtù cristiane
Le virtù sono un piatto della cucina teramana, caratteristico del primo di maggio. Questa preparazione unica nel panorama gastronomico italiano rappresenta una vera e propria celebrazione della primavera e del rinnovamento della natura. Il nome deriva dalle sette virtù cristiane, simboleggiate dai sette tipi diversi di pasta fresca utilizzati nella ricetta.
La preparazione delle virtù richiede giorni di preparazione e una pazienza certosina. Si inizia mettendo in ammollo diverse varietà di legumi secchi: ceci, fagioli cannellini, borlotti, lenticchie, fave e cicerchie. Contemporaneamente si prepara un soffritto ricchissimo con lardo, pancetta, costine di maiale, ossi di prosciutto e verdure di stagione. Il tutto viene unito in un grande paiolo di rame, dove cuoce lentamente per ore.
L’elemento distintivo delle virtù è la presenza di sette formati diversi di pasta fresca: sagne, tagliatelle, quadrucci, maltagliati, ditaloni, maccheroncini e fregula. Ogni tipo di pasta viene aggiunto in momenti diversi della cottura, creando un contrasto di consistenze affascinante. Il piatto finale è una zuppa densa e nutriente, arricchita con verdure primaverili come spinaci, bietole, lattuga e erbe spontanee raccolte nei campi circostanti Teramo.
Scrippelle ‘mbusse: la crêpe abruzzese nel brodo
Le scrippelle ‘mbusse rappresentano una delle preparazioni più raffinate della cucina popolare abruzzese. Si tratta di sottilissime crêpe salate, preparate con un impasto di uova, farina, acqua e prezzemolo tritato finemente, che vengono poi immerse nel brodo bollente di carne o cappone.
La tecnica di preparazione richiede una padella perfettamente antiaderente e un movimento rotatorio preciso per distribuire uniformemente l’impasto sulla superficie. Le scrippelle devono risultare sottili come un velo, dorate ma non croccanti, elastiche al punto giusto per poter essere arrotolate senza rompersi. Una volta pronte, vengono cosparse di pecorino grattugiato e arrotolate come piccoli cannelloni.
L’immersione nel brodo bollente è il momento magico: le scrippelle si gonfiano leggermente, assorbendo i sapori del brodo mentre mantengono la loro consistenza delicata. Il risultato è un piatto di eleganza rustica straordinaria, dove la semplicità degli ingredienti si trasforma in un’esperienza gustativa complessa e appagante. Ogni cucchiaio rivela note diverse: il sapore intenso del brodo, la cremosità del formaggio fuso e la delicatezza della pasta.
Secondi piatti della tradizione montana
Agnello alle erbe selvatiche: sapori di alta quota
L’agnello alle erbe selvatiche rappresenta l’essenza della cucina pastorale abruzzese. Questo piatto nasce dalla necessità dei pastori di cucinare la carne durante la transumanza, utilizzando esclusivamente gli ingredienti che la montagna offriva spontaneamente. La preparazione tradizionale prevede l’utilizzo di spalle o cosciotti giovani, marinati per ore in vino bianco locale con un bouquet di erbe aromatiche raccolte sui pascoli d’altura.
Le erbe utilizzate variano secondo la stagione e l’altitudine: timo serpillo, maggiorana selvatica, menta di montagna, rosmarino, salvia e l’immancabile nepitella, un’erba aromatica tipicamente abruzzese dal profumo intenso e leggermente piccante. La marinatura avviene in recipienti di terracotta, dove la carne riposa per almeno dodici ore, assorbendo lentamente tutti gli aromi.
La cottura tradizionale avviene in grandi pentole di ferro sul fuoco di legna, con una tecnica di brasatura lenta che può durare diverse ore. L’agnello viene prima rosolarato in olio extravergine locale, poi bagnato con il vino della marinatura e fatto cuocere a fuoco bassissimo. Il risultato è una carne tenerissima che si sfalda alla forchetta, profumata di montagna e dal sapore intenso ma mai aggressivo, accompagnata da un sugo ricco perfetto per condire polenta o pane casareccio.
Coratella con carciofi: l’arte del recupero
La coratella con carciofi rappresenta la filosofia del non spreco tipica della cucina contadina abruzzese. Questo piatto utilizza le interiora dell’agnello o del capretto – cuore, fegato, polmoni e milza – trasformandole in una preparazione ricca e saporita che un tempo costituiva un piatto da festa per le famiglie meno abbienti.
La preparazione inizia con una pulizia meticolosa delle interiora, che vengono lavate più volte in acqua acidulata con limone per eliminare ogni residuo di sangue. Il fegato viene tagliato a fettine sottili, il cuore a dadini, mentre polmoni e milza vengono tritati grossolanamente. I carciofi utilizzati sono quelli locali spinosi, più piccoli e saporiti di quelli comuni, puliti a vivo e tenuti in acqua acidulata per evitare l’ossidazione.
La cottura avviene in due fasi: prima si rosola la coratella in olio extravergine con aglio, cipolla e sedano tritati finemente, poi si aggiungono i carciofi tagliati a spicchi e si bagna il tutto con vino bianco secco. La cottura prosegue a fuoco dolce per circa quaranta minuti, durante i quali si sviluppano sapori complessi e avvolgenti. Il piatto finale è una sinfonia di consistenze e sapori, dove l’amarognolo dei carciofi bilancia perfettamente la ricchezza delle interiora, creando un equilibrio gustativo di rara intensità.
Dolci della tradizione: quando la semplicità diventa arte
Pizza doce: la torta delle grandi occasioni
La pizza doce è una torta tipica delle celebrazioni, dai matrimoni agli anniversari, caratterizzata da strati di pan di Spagna bagnato con caffè e liquori alternati a creme pasticcera e al cioccolato. Questo dolce monumentale rappresenta l’apogeo della pasticceria abruzzese e richiede giorni di preparazione e una tecnica sopraffina per essere realizzato correttamente.
La base è costituita da pan di Spagna altissimo, preparato con uova fresche di galline ruspanti e farina doppio zero setacciata più volte. Il segreto per ottenere la giusta sofficità risiede nella montatura perfetta delle uova e nella delicatezza della mescolatura, che deve avvenire dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Una volta cotto e raffreddato, il pan di Spagna viene tagliato in dischi dello stesso spessore.
L’assemblaggio è un’operazione complessa che richiede precisione millimetrica. Ogni disco viene bagnato con una bagna preparata con caffè forte, rum e liquore all’amaretto, poi farcito con crema pasticcera aromatizzata alla vaniglia e crema al cioccolato fondente. L’alternanza delle creme crea striature visive spettacolari che si rivelano al taglio. La superficie viene ricoperta con una glassa al cioccolato lucida e decorata con confetti di Sulmona colorati, che conferiscono al dolce il suo aspetto festoso e regale.
Ferratelle: l’arte della cialdina abruzzese
Le ferratelle, conosciute anche come pizzelle, sono cialde croccanti preparate con un ferro speciale che imprime sulla superficie disegni geometrici tradizionali. Questi dolci rappresentano una delle tradizioni più antiche dell’Abruzzo dolciario e ogni famiglia custodisce gelosamente la propria ricetta segreta, tramandata di generazione in generazione.
L’impasto base è sorprendentemente semplice: uova, zucchero, farina, olio extravergine d’oliva e aromi. La qualità degli ingredienti fa la differenza: le uova devono essere freschissime, lo zucchero finissimo, l’olio di prima spremitura a freddo. Gli aromi tradizionali includono buccia di limone grattugiata, estratto di vaniglia o anice, che conferiscono alle ferratelle il loro profumo inconfondibile.
Il ferro per ferratelle è uno strumento tramandato di famiglia in famiglia, spesso decorato con stemmi o iniziali. La cottura richiede esperienza e intuito: l’impasto viene versato al centro del ferro caldo e pressato fino ad ottenere una cialda sottilissima e dorata. Il timing è cruciale: pochi secondi di troppo e la ferratella brucia, troppo poco e rimane morbida. Una volta cotte, possono essere modellate a cono mentre sono ancora calde, per essere poi farcite con crema o ricotta dolce, oppure lasciate piatte e servite con miele di millefiori abruzzese.
Specialità di mare della costa teatina
Brodetto di San Vito: la zuppa dei pescatori
Il brodetto di San Vito Chietino rappresenta una delle interpretazioni più autentiche della zuppa di pesce adriatica. A differenza di altre versioni più note, questa preparazione mantiene un carattere rustico e genuino che riflette la tradizione marinara del piccolo borgo chietino, famoso per i suoi trabocchi e la pesca tradizionale.
La particolarità di questo brodetto risiede nella selezione del pesce, che deve provenire esclusivamente dalle acque antistanti San Vito. Si utilizzano pesci di scoglio come scorfani, tracine, gallinelle, triglie, insieme a molluschi e crostacei locali. Il fondo di cottura si prepara con le teste e le lische dei pesci più grandi, soffritte con sedano, carota, cipolla e pomodori San Marzano, poi diluite con vino bianco secco della zona.
La cottura segue una sequenza precisa: prima si immergono i pesci dalla carne più soda, poi gradualmente quelli più delicati, in modo che tutto sia pronto contemporaneamente. L’aggiunta finale di prezzemolo fresco, aglio e peperoncino piccante conferisce al brodetto quel carattere deciso tipico della cucina abruzzese. Il piatto viene servito bollente, accompagnato da fette di pane casereccio abbrustolito e strofinato con aglio, che assorbe il sugo saporito creando un contrasto di consistenze perfetto.
Cozze allo zafferano: l’oro del mare
Le cozze allo zafferano rappresentano un matrimonio perfetto tra i frutti del mare adriatico e lo zafferano dell’Aquila DOP, una delle spezie più pregiate al mondo. Questo piatto unisce la tradizione marinara con l’eccellenza montana, creando una preparazione unica nel panorama gastronomico mediterraneo.
Le cozze utilizzate sono rigorosamente nostrane, raccolte negli allevamenti tra Ortona e Vasto, caratterizzate da conchiglie scure e polpa carnosa dal sapore intenso di mare. La pulizia richiede particolare attenzione: ogni mollusco viene spazzolato individualmente per rimuovere alghe e incrostazioni, eliminando il bisso e scartando quelle che non si chiudono al tocco.
La preparazione prevede una doppia cottura: prima le cozze vengono aperte al vapore con vino bianco, aglio e prezzemolo, raccogliendo il loro liquido di cottura filtrato. Successivamente, la polpa viene saltata in padella con olio extravergine, scalogno tritato finemente e una generosa spolverata di zafferano, che conferisce al piatto il caratteristico colore dorato e un aroma intenso e avvolgente. Il risultato finale è un secondo piatto elegante e raffinato, dove il sapore marino delle cozze si esalta grazie alle note floreali e leggermente amare dello zafferano aquilano.
I tesori liquidi dell’Abruzzo: bevande della tradizione
Centerba: l’elisir di lunga vita delle montagne
Il Centerba rappresenta il liquore simbolo dell’Abruzzo, un elisir dalle proprietà digestive e tonificanti preparato con un’infusione di oltre cento erbe officinali raccolte sui monti della Majella e del Gran Sasso. Tra i liquori tipici abruzzesi si annovera il Centerba o cianterba, una preparazione che affonda le sue radici nella tradizione erboristica monastica medievale.
La ricetta originale del Centerba è un segreto custodito gelosamente dalle distillerie storiche abruzzesi, tramandata oralmente di generazione in generazione. La raccolta delle erbe segue un calendario preciso: ogni pianta deve essere colta nel momento di massima concentrazione dei principi attivi, preferibilmente nelle prime ore dell’alba quando la rugiada mantiene intatti gli oli essenziali. Tra le erbe più importanti si trovano genziana maggiore, achillea millefoglie, artemisia, timo, santoreggia, menta, melissa e decine di altre specie spontanee.
Il processo di produzione richiede mesi di lavorazione: le erbe fresche vengono messe in infusione in alcol purissimo per almeno quaranta giorni, in recipienti di vetro esposti alternativamente al sole e all’ombra. Successivamente il liquido viene filtrato, addolcito con sciroppo di zucchero e fatto riposare in botti di rovere per altri tre mesi. Il Centerba finale presenta una gradazione alcolica elevata (70°) e un colore verde intenso, con un bouquet aromatico complesso che spazia dalle note erbacee a quelle balsamiche, culminando in un finale persistente e leggermente amaro che favorisce la digestione.
Ratafia di amarene: il liquore dell’amore
La Ratafià nasce dal connubio tra le qualità del Montepulciano d’Abruzzo e le proprietà aromatiche delle ciliegie amarelle tipiche di Raiano. Questo liquore dal colore rosso rubino rappresenta una delle preparazioni più romantiche della tradizione abruzzese, spesso regalato durante i fidanzamenti come simbolo di amore eterno.
La preparazione della Ratafia segue un rituale preciso che inizia con la raccolta delle amarene nel momento di perfetta maturazione, quando il rapporto tra zuccheri e acidità raggiunge l’equilibrio ideale. I frutti vengono selezionati uno ad uno, scartando quelli danneggiati o troppo maturi. La tecnica tradizionale prevede di incidere leggermente ogni amarena per favorire la fuoriuscita del succo durante la macerazione.
Le amarene vengono messe in infusione nel Montepulciano d’Abruzzo DOCG per un periodo che varia dai tre ai sei mesi, a seconda dell’intensità di colore e sapore desiderata. Durante questo periodo, il vino si arricchisce degli aromi fruttati delle amarene, acquisendo note di ciliegia matura, mandorla amara e una leggera speziatura. Terminata la macerazione, il liquido viene filtrato e addolcito con sciroppo di zucchero, ottenendo un liquore dal gusto equilibrato, dolce ma non stucchevole, con una persistenza aromatica che ricorda le confetture casalinghe della nonna.
Genziana liquore: l’amaro della montagna
La Genziana è uno dei tipici digestivi abruzzesi, nata da lunghe infusioni di ricette antiche sapientemente conservate. Questo liquore amaro rappresenta l’essenza della farmacopea popolare abruzzese, preparato con le radici della Genziana Lutea che cresce spontaneamente sui prati d’altura della Majella e del Gran Sasso.
La Genziana Lutea è una pianta protetta che può essere raccolta solo con autorizzazione e in quantità limitate. Le radici, che possono raggiungere dimensioni notevoli dopo decenni di crescita, vengono estratte dal terreno nel periodo autunnale quando la concentrazione di principi attivi è massima. La preparazione richiede una fase di essiccazione all’aria aperta per alcune settimane, durante le quali le radici perdono l’umidità mantenendo intatti i composti amaricanti.
L’infusione avviene in alcol purissimo per un periodo minimo di tre mesi, durante i quali le radici rilasciano lentamente i loro principi attivi, conferendo al liquido un colore ambrato e un sapore intensamente amaro. Il liquore di genziana abruzzese si distingue per la sua purezza aromatica: al palato si percepisce immediatamente l’amaro caratteristico, seguito da note terrose e vegetali che ricordano il sottobosco montano. La persistenza è notevole, con un finale che lascia in bocca una sensazione di freschezza balsamica che stimola la digestione e dona una sensazione di benessere generale.