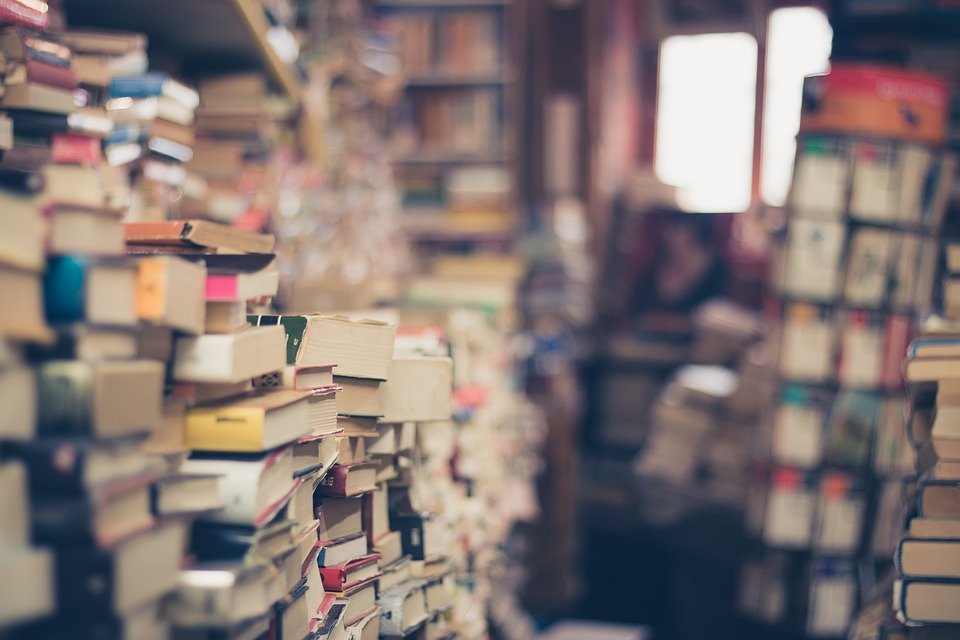Nel mondo del caffè contemporaneo, sempre più attento alla sostenibilità e alla valorizzazione dell’intera filiera produttiva, sta emergendo con prepotenza un protagonista inaspettato: la cascara. Questo termine spagnolo, che significa letteralmente “buccia” o “guscio”, identifica l’involucro esterno della ciliegia di caffè, tradizionalmente considerato uno scarto nella produzione della pregiata bevanda. Per secoli questi sottoprodotti sono stati semplicemente compostati o gettati via, creando persino problemi ambientali nelle regioni produttrici. Oggi, invece, assistiamo a una rinascita di questa materia prima, trasformata in una bevanda dal carattere unico che racconta storie antiche eppure sorprendentemente contemporanee.
La tradizione di utilizzare la cascara per preparare infusi risale a centinaia di anni fa in paesi come lo Yemen, dove è conosciuta come “qishr”, e in Bolivia, dove prende il nome di “sultana”. Qui, mentre l’Occidente scopriva e si innamorava del caffè come lo conosciamo oggi, le popolazioni locali già apprezzavano le proprietà organolettiche e nutritive di queste bucce essiccate. Un patrimonio culturale che oggi viene riscoperto e reinterpretato da baristi, mixologist e chef di tutto il mondo.
Dal campo alla tazza: il viaggio della cascara
Il processo di produzione della cascara inizia nei campi di caffè, dove le ciliegie mature vengono raccolte principalmente a mano per garantire la selezione dei frutti al giusto grado di maturazione. Una volta raccolte, le ciliegie subiscono la fase di decorticazione, durante la quale la polpa esterna viene separata dai preziosi chicchi. È proprio questa polpa, opportunamente essiccata al sole su patios o letti rialzati, a diventare cascara.
La qualità della cascara dipende profondamente dalla cura con cui viene lavorata. I produttori più attenti selezionano solo ciliegie perfettamente mature, evitando quelle danneggiate o acerbe, e controllano meticolosamente il processo di essiccazione per prevenire la formazione di muffe. Il risultato è un prodotto dall’aroma intenso, complesso e sorprendentemente diverso da quello del caffè che conosciamo.
Recenti studi hanno dimostrato che la cascara mantiene una concentrazione significativa di antiossidanti e contiene meno caffeina rispetto al caffè tradizionale, rendendola un’alternativa interessante per chi cerca stimolazione moderata. Ricerche condotte dall’Università di Brandford nel 2022 hanno evidenziato come il contenuto di polifenoli nella cascara essiccata correttamente possa risultare fino a tre volte superiore rispetto a quello presente in alcuni tè verdi.
Un profilo sensoriale unico
Chi si avvicina alla cascara aspettandosi un sapore simile al caffè rimarrà sorpreso. L’infuso che si ottiene da queste bucce essiccate rivela un mondo aromatico completamente diverso. Le note predominanti spaziano dall’uva passa alla prugna secca, dal tamarindo ai fichi, con sfumature che ricordano talvolta il tè hibiscus o i frutti di bosco.
La varietà della pianta di caffè, il terroir e le tecniche di lavorazione influenzano profondamente il profilo organolettico finale. Una cascara proveniente dalle alture del Costa Rica potrà risultare floreale e leggermente agrumata, mentre quelle provenienti dall’Etiopia tendono a esprimere note più fruttate e complesse. Questa variabilità rappresenta una ricchezza straordinaria per baristi e mixologist, che possono giocare con diverse origini per creare esperienze di degustazione uniche.
La cascara di alta qualità dovrebbe presentarsi come scaglie di colore bruno-rossastro, uniformi e senza tracce di muffe. L’aroma a secco risulta intenso, fruttato e leggermente dolce. All’infusione, che idealmente avviene in acqua a 95°C per circa 4-5 minuti, sprigiona un bouquet aromatico che sorprende per complessità ed eleganza.
La cascara nella mixology contemporanea
Nel panorama della mixology d’avanguardia, la cascara sta rapidamente guadagnando terreno come ingrediente versatile e sostenibile. Pionieri del settore come Alex Kratena del Tayer + Elementary di Londra o Gabriele Stillitani del Locale Firenze hanno integrato sciroppi e infusi di cascara nelle loro creazioni, dando vita a cocktail dal carattere inconfondibile.
Lo sciroppo di cascara, ottenuto facendo ridurre l’infuso con zucchero di canna, diventa un complemento ideale per rivisitare grandi classici come l’Old Fashioned o il Whiskey Sour. La sua acidità naturale, bilanciata da note dolci e fruttate, crea un contrappunto interessante ai distillati più strutturati come whisky invecchiati o rum scuri.
Particolarmente interessante è l’utilizzo della cascara in abbinamento a vermut artigianali e amari botanici, dove le sue note fruttate esaltano la complessità delle erbe e delle spezie. Non mancano sperimentazioni che vedono la cascara protagonista di fermentazioni controllate, per ottenere bevande leggermente alcoliche dal carattere unico.
Dal bicchiere al piatto: applicazioni gastronomiche
L’utilizzo della cascara si sta rapidamente espandendo oltre il mondo delle bevande per approdare nella gastronomia d’autore. Chef innovativi stanno esplorando le potenzialità di questo ingrediente in preparazioni sia dolci che salate. L’infuso concentrato di cascara può diventare base per sorbetti rinfrescanti o gelati dal carattere inconfondibile, mentre la polvere di cascara essiccata e finemente macinata viene utilizzata come spezia per aromatizzare impasti e salse.
Nei laboratori di pasticceria più all’avanguardia, la cascara trova applicazione in ganache al cioccolato, dove le sue note fruttate creano un dialogo interessante con cacao monorigine di qualità. Alcuni panificatori la stanno integrando in lievitati a lunga fermentazione, dove contribuisce con note aromatiche complesse e un leggero tocco acidulo.
Sul fronte salato, marinature a base di cascara stanno dimostrando interessanti capacità di tenderizzare le carni, specialmente selvaggina e tagli bovini da lunga cottura. La presenza di tannini e acidi naturali nella buccia essiccata favorisce processi simili a quelli che si ottengono con il vino rosso nelle ricette tradizionali.
Sostenibilità e futuro
In un’epoca in cui la sostenibilità non è più opzione ma necessità, la rivalutazione della cascara rappresenta un caso esemplare di economia circolare applicata al mondo dell’enogastronomia. Trasformare quello che per secoli è stato considerato uno scarto in un prodotto di valore non solo riduce l’impatto ambientale della produzione di caffè, ma crea anche nuove opportunità economiche per le comunità produttrici.
Studi recenti condotti dall’Organizzazione Internazionale del Caffè indicano che per ogni tonnellata di caffè verde prodotto si generano circa 1,8 tonnellate di cascara. Con una produzione mondiale che supera i 10 milioni di tonnellate annue di caffè verde, il potenziale di questo sottoprodotto appare evidente.
Diverse cooperative di piccoli produttori in paesi come El Salvador, Colombia e Guatemala hanno già avviato programmi di valorizzazione della cascara, creando nuovi flussi di reddito e opportunità di diversificazione. Le certificazioni biologiche e di commercio equo stanno iniziando a includere criteri specifici per la lavorazione sostenibile di questo sottoprodotto, garantendo standard qualitativi e condizioni di lavoro adeguate.
La ricerca scientifica sta inoltre esplorando ulteriori applicazioni della cascara, dai cosmetici naturali ai materiali biocompositi, ampliando ulteriormente le prospettive di questo affascinante sottoprodotto del caffè. La trasformazione da scarto a risorsa rappresenta un modello virtuoso che potrebbe essere replicato in altri settori dell’agroalimentare, contribuendo a un futuro più sostenibile per l’intera filiera.

Curioso per natura, vivo la vita come se non ci fosse un domani.