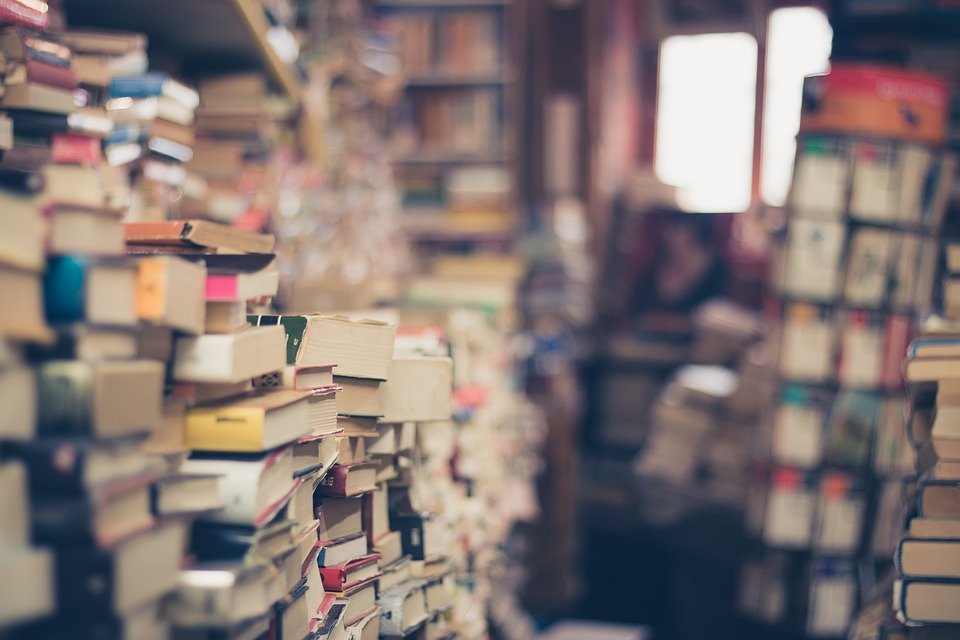In genere è vista come un “caso spiacevole”, “un brutto imprevisto” ma secondo alcuni, quella che viene chiamata sfortuna sarebbe in realtà frutto dell’invidia e di occhi malevoli.
Per questi ultimi, infatti, esistono persone in grado di generare eventi spiacevoli o malesseri fisici con lo sguardo o, più comunemente, di “fare il malocchio”. Le origini di questa “capacità” sono molto antiche: la prima testimonianza scritta in merito, risale al 1500 con Agrippa e il suo libro La Filosofia Occulta, in cui sostiene che una vera e propria forza del male si serva di un fascinatore che, attraverso lo sguardo, arriva fino al cuore del fascinato portandogli disgrazie di ogni sorta.
Questa credenza, ad oggi priva di evidenza scientifica ma considerata a metà strada tra un elemento folcloristico-culturale di un popolo e una vera e propria superstizione, ha radici profonde in tutto il mondo: ad esempio, in Italia il malocchio è visto come espressione della gelosia e dei sentimenti negativi che si provano e si jettano verso una persona considerata “troppo fortunata”; in russo, malocchio si dice sglaz e significa letteralmente “dall’occhio”; in Spagna c’è il mal de ojo a sottolineare il male che esce dall’occhio. Da sempre accostato all’idea di magia, di occulto e di profano, si può, invece, analizzare il fenomeno del malocchio in maniera inusuale e originale paragonandolo ad una malattia globalmente diffusa che ha come virus il cosiddetto jettatore.
Come tutte le malattie, in effetti, presenta “sintomi” che possono manifestarsi sotto forma di mal di testa, nausea, cattivo umore, depressione o veri e propri eventi negativi sul lavoro e nella vita privata. La cura viene somministrata dal “medico del malocchio”: una persona anziana, spesso una donna, grazie al suo sesto senso percepisce l’energia negativa intorno al “malato” e con la “terapia”, scaccia il male provocato dalla jettatura.
Nello specifico, in Italia si esegue il rito dell’olio in cui si riempie d’acqua un piatto fondo e, reggendolo con la mano sinistra, si poggia vicino al paziente colpito dal malocchio. Dopo aver recitato per tre volte la formula di rito che varia di paese in paese, si fa tre volte il segno della croce e, toccando i bordi del piatto, si ripete il segno della croce tre volte. A quel punto, si buttano tre gocce d’olio nell’acqua e se ne osserva la forma: se tendono ad allargarsi, il malocchio è presente; se invece tendono a scomparire, il malocchio c’è da tanto tempo e sarà più difficile da far passare. Si viene considerati guariti solo quando le circonferenze formate dalle gocce sono molto piccole.
In Messico e in America Centrale, invece, ci si affida a un rito in cui i milagros, piccoli ciondoli dalle forme più varie (dalla riproduzione delle parti del corpo agli animali), si applicano dove si crede si sia depositato il male mentre si recitano delle preghiere atte a far guarire dalla fattura. Inoltre, come in tutte le malattie “classiche”, oltre alla cura esiste anche una vasta forma di prevenzione: le “difese immunitarie” contro il malocchio sono costituite soprattutto da amuleti da portare con sé contro la jella. Ognuno di loro ha caratteristiche e forme particolari che dipendono molto dal luogo di provenienza e dal significato attribuitogli. Spesso hanno forme che rappresentano parti del corpo considerate emblema della protezione come l’Occhio di Allah che ti guarda le spalle raffigurato su ogni tipo di oggetto o utilizzato come ciondolo da portare con sé. Questo simbolo turco sembra risalire addirittura all’epoca dei Sumeri e viene da sempre associato alla protezione dalla cattiva sorte.
Un altro simbolo comunemente noto contro il malocchio è la hamsa, dagli ebrei chiamato Mano di Miriam e dai musulmani Mano di Fatima, a rappresentare la mano che come uno scudo protegge e respinge le avversità. Anche gli animali sono stati elevati a simbolo di prevenzione contro la cattiva sorte: basti pensare al cavallo dorato dala in Svezia, al rospo dorato in Cina e al coleottero egiziano che, sia indossati come spille e ciondoli sia appesi alle porte, proteggono contro gli spiriti maligni e le forze oscure in generale. Non solo, alcuni animali considerati protettori contro i mali sono diventati addirittura “simboli nazionali” a rappresentanza e riconoscimento dell’intero Paese a cui appartengono. Ci si riferisce, ad esempio, ai toritos de pucará peruviani e boliviani che venivano posti sopra i tetti in segno di equilibrio tra il bene e il male, all’elefante thailandese e al gatto della fortuna giapponese che con il movimento della zampa, inteso dagli stranieri come un saluto, richiama la fortuna e scaccia via il malocchio.
Decisamente più folcloristica è, invece, la “terapia di prevenzione” italiana tipica soprattutto del sud della penisola. L’amuleto contro il malocchio per eccellenza è senza dubbio il corno, anche detto o’ curniciello, le cui origini risalgono al 3500 a.C. Da simbolo di fertilità e ricchezza, dopo l’epoca romana acquisisce significato di protezione, ma solo se risponde a delle caratteristiche specifiche: deve essere rosso, di un materiale prezioso come il corallo e viene “attivato” regalandolo alla persona che si desidera proteggere. Non solo, la tradizione italiana contro la jettatura comprende anche i cosiddetti scongiuri, eseguiti sollevando indice e mignolo delle mani a formare delle corna e toccando ferro o legno in base alla credenza secondo cui questi sono gli elementi che respingono il diavolo.
Insomma, che venga inteso come una superstizione, una maledizione o una strana malattia, il malocchio possiede significati profondi, nascosti nell’antichissimo desiderio dell’uomo di dare una motivazione valida agli avvenimenti funesti e inspiegabili della vita. E seppure non esistano razionalmente amuleti magici che conferiscono protezione assoluta dalle avversità, i simboli e le tradizioni contro la jella hanno il grande potere di unire i popoli nella lotta contro il male dando loro la forza di proteggersi e combatterlo, ognuno a modo proprio ma con un unico comune denominatore: la speranza.