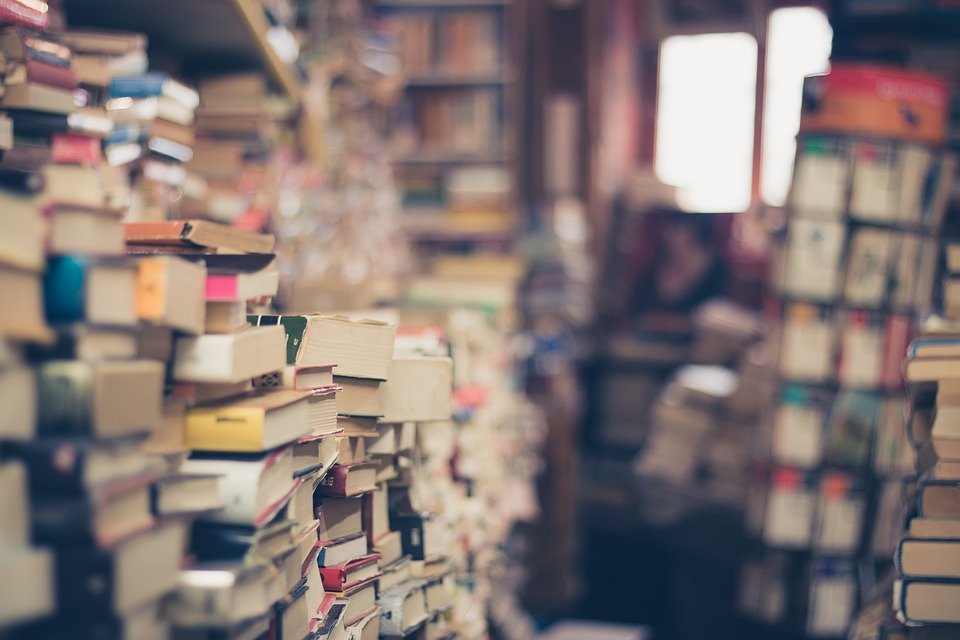Nella luce dorata di un pomeriggio di Carnevale, mentre le maschere danzano per le strade di Venezia, Milano o Viareggio, una cascata multicolore cade dal cielo, trasformando l’aria in una tela vivente. I coriandoli, protagonisti silenziosi e onnipresenti del Carnevale, racchiudono una storia affascinante che affonda le radici nell’Italia medievale, quando nessuno avrebbe immaginato che piccoli cerchi di carta avrebbero rivoluzionato le celebrazioni carnevalesche in tutto il mondo.
L’origine dei coriandoli è sorprendentemente gastronomica. Nel Medioevo italiano, i semi di coriandolo – da cui deriva il nome – venivano ricoperti di zucchero per creare confetti aromatizzati. Questi dolcetti sferici venivano lanciati durante le feste nobiliari e, in particolare, durante il Carnevale come simbolo di prosperità e abbondanza. Un gesto apparentemente frivolo che nascondeva significati profondi: il lancio rappresentava la distribuzione della ricchezza e la momentanea sospensione delle rigide gerarchie sociali che caratterizzavano l’epoca.
L’evoluzione storica: da dolce a simbolo festivo
La tradizione dei confetti zuccherati, antenati diretti dei coriandoli, ha origini che risalgono all’epoca romana, quando durante le cerimonie nuziali si usava lanciare noci e datteri come simbolo di fertilità. Questa usanza si trasformò gradualmente nell’Alto Medioevo, quando i semi di coriandolo zuccherati divennero protagonisti nelle feste di corte. Nel Rinascimento italiano, particolarmente a Venezia e Firenze, i confetti aromatizzati erano considerati un lusso straordinario, prodotti da abili confettieri che custodivano gelosamente le loro ricette.
La documentazione storica attesta che già nel XV secolo, durante il celebre Carnevale di Venezia, i nobili lanciavano dalle gondole preziosi confetti al passaggio della folla. Il Diario del Sanudo, cronaca veneziana del 1500, descrive “una pioggia dolce di confetti” durante la festa del giovedì grasso, evidenziando come questa usanza fosse già consolidata. Nel 1597, una disposizione del Senato veneziano tentò addirittura di limitare l’uso dei confetti durante il Carnevale, poiché il loro costo eccessivo stava provocando dissesti finanziari tra le famiglie nobili impegnate in una competizione di ostentazione del lusso.
La transizione dai confetti commestibili ai coriandoli di carta avvenne gradualmente. Un passaggio intermedio furono i confetti di gesso, documentati a Roma e Napoli nel XVIII secolo: più economici di quelli zuccherati, permettevano di partecipare al lancio anche a chi non poteva permettersi i costosi dolciumi. Tuttavia, questi surrogati provocavano danni alle vesti e, talvolta, ferite agli occhi, portando a ripetuti tentativi di regolamentazione da parte delle autorità comunali nelle principali città italiane.
La controversa paternità: Mangilli contro Fenderl
La vera trasformazione avvenne nel 1875, quando l’ingegnere milanese Enrico Mangilli ebbe un’intuizione destinata a cambiare per sempre il volto del Carnevale. Osservando i costosi confetti zuccherati che venivano lanciati durante le feste, pensò di creare una versione economica e accessibile utilizzando piccoli ritagli circolari di carta.
Tuttavia, la paternità di questa invenzione è oggetto di una storica disputa. Ettore Fenderl, fisico e inventore triestino, rivendicò con forza di essere il vero ideatore dei coriandoli di carta. Secondo numerose testimonianze dell’epoca, Fenderl avrebbe presentato la sua invenzione durante il Carnevale di Trieste nel 1876, sostenendo che l’idea gli fosse venuta mentre lavorava in una cartiera. La contesa tra Mangilli e Fenderl divenne così accesa che entrambi tentarono di brevettare l’invenzione, generando una battaglia legale che appassionò l’opinione pubblica italiana di fine Ottocento.
La “Gazzetta di Milano” del febbraio 1876 riporta che Mangilli presentò domanda di brevetto descrivendoli come “dischetti di carta colorata a uso festivo”, mentre la “Rivista di Trieste” dello stesso anno documenta la richiesta di Fenderl, che li definiva “stelline di carta per celebrazioni”. Il contenzioso si complicò ulteriormente quando un terzo pretendente, il tipografo napoletano Ludovico Marinelli, sostenne di aver prodotto “pezzetti di carta perforata” già dal 1874, sebbene con minore risonanza commerciale.
La questione non venne mai risolta definitivamente, ma le prove documentali tendono a sostenere la versione di Mangilli, il cui nome compare in una fattura della Cartiera Binda di Milano datata dicembre 1875, dove si menzionano esplicitamente “macchine per la produzione di dischetti di carta per le feste di Carnevale”. Fenderl, d’altro canto, godeva dell’appoggio della stampa triestina e viennese, che contribuì a diffondere la sua versione nei territori dell’Impero austro-ungarico.
Sebbene le cronache dell’epoca tendano a riconoscere il primato a Mangilli, la figura di Fenderl rimane inestricabilmente legata alla diffusione dei coriandoli nell’area adriatica e nei territori dell’Impero austro-ungarico. Questa competizione, anziché diminuire il valore dell’invenzione, ne accelerò paradossalmente la popolarità, trasformando rapidamente i coriandoli di carta in un fenomeno transnazionale.
I primi coriandoli di carta furono prodotti riciclando gli scarti delle cartiere e delle tipografie milanesi e triestine, in particolare i residui delle perforazioni delle schede utilizzate nei primi telai meccanici. Questa origine legata al riutilizzo creativo conferisce ai coriandoli una dimensione sorprendentemente moderna e sostenibile.
La diffusione globale di una tradizione italiana
Dalla Milano e Trieste di fine Ottocento, i coriandoli di carta iniziarono la loro conquista delle celebrazioni carnevalesche in tutto il mondo. Particolarmente significativa fu la loro adozione nel Carnevale di Nizza in Francia e nelle feste di New Orleans negli Stati Uniti, dove assunsero il nome francese di “confetti” creando una curiosa inversione linguistica rispetto all’originale italiano.
La produzione industriale iniziò nei primi anni del Novecento, quando speciali macchine perforatrici permettevano di ottenere migliaia di coriandoli in pochi minuti. Questa industrializzazione coincise con la trasformazione del Carnevale da festa principalmente aristocratica a celebrazione popolare, accessibile a tutte le classi sociali.
Il simbolismo nascosto nei cerchi di carta
Al di là della loro funzione decorativa, i coriandoli racchiudono significati simbolici che trascendono le diverse culture. Il loro carattere effimero e transitorio riflette perfettamente lo spirito del Carnevale: un momento di gioia destinato a dissolversi, proprio come il periodo festivo che precede la Quaresima.
La forma circolare, inoltre, non è casuale: rappresenta la ciclicità del tempo e delle stagioni, il perpetuo ritorno delle festività e la continuità delle tradizioni popolari attraverso le generazioni. I colori vivaci simboleggiano la diversità umana che, nel contesto carnevalesco, si fonde in un’unica espressione di gioia collettiva.
I coriandoli nell’era moderna: tradizione e innovazione
Oggi, mentre celebriamo il Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale prima dell’inizio della Quaresima, i coriandoli continuano a evolversi. Accanto ai tradizionali dischetti di carta, sono comparsi coriandoli biodegradabili realizzati con materiali ecosostenibili, coriandoli metallizzati per spettacoli e celebrazioni più sofisticate, e persino coriandoli digitali nelle celebrazioni virtuali.
Nonostante queste innovazioni, il fascino originario dei semplici coriandoli di carta rimane inalterato. In un’epoca dominata dalla tecnologia, c’è qualcosa di profondamente umano e universale nell’atto di lanciare in aria piccoli pezzi di carta colorata, creando un istante di bellezza condivisa destinato a dissolversi.
L’eredità duratura di una tradizione effimera
I coriandoli, nella loro apparente semplicità, incarnano l’essenza stessa del Carnevale: la celebrazione dell’istante, la gioia momentanea che trascende le preoccupazioni quotidiane, la magia fugace di un mondo capovolto dove le regole ordinarie sono temporaneamente sospese.
Mentre osserviamo i bambini raccogliere questi minuscoli cerchi colorati dalle strade dopo le parate di Carnevale, assistiamo inconsapevolmente alla continuazione di una tradizione che ha attraversato secoli e continenti, unendo generazioni nel semplice piacere di una pioggia di colori.
In questo Martedì Grasso, mentre i coriandoli danzano nell’aria delle città italiane e del mondo, portiamo con noi la consapevolezza che in ogni piccolo cerchio di carta colorata è racchiusa una storia millenaria di creatività, adattamento e gioia condivisa – valori che, proprio come i coriandoli, continuano a colorare le nostre vite ben oltre la fine del Carnevale.

Direttore editoriale di No#News Magazine.
Viaggiatore iperattivo, tenta sempre di confondersi con la popolazione indigena.
Amante della lettura, legge un po’ di tutto. Dai cupi autori russi, passando per i libertini francesi, attraverso i pessimisti tedeschi, per arrivare ai sofferenti per amore, inglesi. Tra gli scrittori moderni tra i preferiti spiccano Roddy Doyle, Nick Hornby e Francesco Muzzopappa.
Melomane vecchio stampo: è chiamato il fondamentalista del Loggione. Ama il dramma verdiano così come le atmosfere oniriche di Wagner. L’opera preferita tuttavia rimane la Tosca.