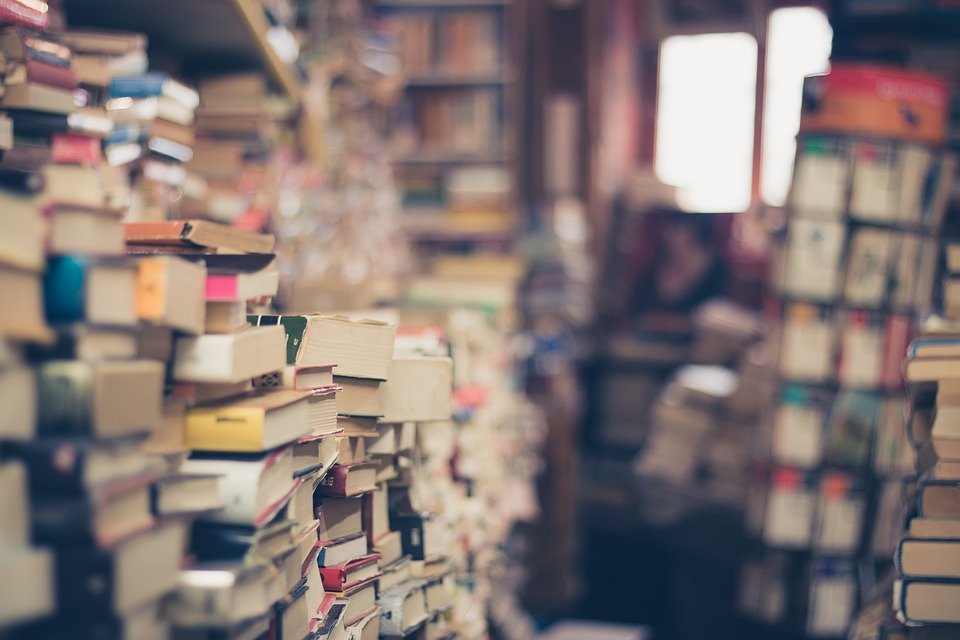Nascosti tra gli edifici e i monumenti storici, i vigneti urbani rappresentano un tesoro enologico spesso sconosciuto ai più. In Italia, paese dalla tradizione vinicola millenaria, questi piccoli appezzamenti coltivati a vite all’interno dei centri abitati stanno vivendo una vera e propria rinascita. Dieci esempi in particolare si distinguono per qualità, storia e fascino, offrendo vini unici nati letteralmente all’ombra di campanili e palazzi.
Milano: la vigna di Leonardo da Vinci
Nel cuore di Milano, all’interno della Casa degli Atellani, si nasconde un vigneto con una storia straordinaria. Donato a Leonardo da Vinci da Ludovico il Moro nel 1498, questo piccolo appezzamento è stato riportato in vita nel 2015 grazie a un attento lavoro di recupero. Oggi produce un vino bianco a base di Malvasia di Candia, la stessa varietà coltivata ai tempi di Leonardo. La produzione è limitatissima, solo 330 bottiglie l’anno, ma rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo, con un sapore che riecheggia quello dei vini rinascimentali.
Torino: il vigneto reale di Villa della Regina
Sulle colline che dominano Torino, i vigneti di Villa della Regina producono dal 2009 un Freisa DOC. Questo vino rosso dalla personalità decisa affonda le sue radici nella storia: la villa fu infatti residenza delle regine di Casa Savoia e i suoi vigneti risalgono al XVII secolo. Oggi, grazie al lavoro di recupero della Soprintendenza e alla collaborazione con produttori locali, questi 0,73 ettari di vigneto urbano danno vita a circa 2500 bottiglie l’anno di un vino che porta con sé tutto il fascino della storia sabauda.
Venezia: il vino dei Dogi
L’isola di San Michele, nel cuore della laguna veneziana, ospita un vigneto di 0,8 ettari che produce il Laguna nel bicchiere, un blend di Malvasia istriana e Vermentino. Questo progetto, nato nel 2002, ha riportato in vita un’antica tradizione vinicola veneziana. I monaci dell’isola coltivavano infatti la vite già nel XV secolo, producendo il vino per i Dogi. Oggi, grazie alla collaborazione tra il Comune di Venezia e un’azienda vinicola locale, questo vigneto urbano regala ogni anno circa 3500 bottiglie di un vino che racchiude in sé i profumi della laguna.
Siena: il Senarum Vinea
Nel cuore di Siena, all’interno delle mura medievali, si nasconde un vero e proprio museo a cielo aperto della viticoltura. Il progetto Senarum Vinea ha recuperato e messo in rete 14 piccoli vigneti storici, per un totale di circa 6000 metri quadrati. Qui si coltivano antiche varietà toscane come il Canaiolo e la Malvasia nera, da cui si ottiene un vino rosso che è un autentico tuffo nella storia enologica senese. La produzione è limitata a poche centinaia di bottiglie, destinate principalmente a scopi di ricerca e promozione.
Bologna: la vigna di Villa Ghigi
Nel parco di Villa Ghigi, a pochi passi dal centro di Bologna, un ettaro di vigneto produce dal 2015 il Pignoletto Villa Ghigi. Questo vino bianco frizzante, tipico dei colli bolognesi, nasce da un progetto di recupero di antichi vitigni portato avanti dalla Fondazione Villa Ghigi in collaborazione con l’Università di Bologna. La produzione, di circa 4000 bottiglie l’anno, è gestita secondo criteri di sostenibilità e rappresenta un esempio virtuoso di agricoltura urbana.
Napoli: la vigna di San Martino
Sulla collina del Vomero, all’interno della Certosa di San Martino, si estende un vigneto di circa 7000 metri quadrati. Qui, grazie al lavoro di recupero dell’associazione Piedi per la Terra, dal 2011 si produce il Lacryma Christi del Vesuvio DOC. Questo vino, ottenuto da uve Caprettone e Catalanesca, rappresenta un pezzo di storia enologica napoletana. La produzione, di circa 2000 bottiglie l’anno, è interamente destinata a scopi benefici e di promozione culturale.
Palermo: i vigneti di Tasca d’Almerita
Nel cuore di Palermo, all’interno di Villa Tasca, si trova un vigneto urbano di 1,5 ettari. Qui la storica famiglia Tasca d’Almerita produce dal 2000 il Rosso del Conte, un blend di Nero d’Avola e Perricone. Questo vino rappresenta un ponte tra la tradizione vinicola siciliana e l’innovazione, con una produzione di circa 8000 bottiglie l’anno che trova spazio nelle carte dei migliori ristoranti italiani.
Trieste: la vigna del Castello di San Giusto
Sul colle di San Giusto, nel cuore di Trieste, un piccolo vigneto di 1000 metri quadrati produce dal 2011 il Castello di San Giusto, un blend di Malvasia e Vitovska. Questo progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune di Trieste e un’azienda vinicola locale, ha riportato in vita un’antica tradizione viticola cittadina. La produzione, di circa 600 bottiglie l’anno, è un vero e proprio omaggio alla storia e alla cultura enologica triestina.
Roma: i vigneti del Pontificio Collegio Urbano
All’interno delle mura vaticane, nei giardini del Pontificio Collegio Urbano, si trova un vigneto di circa 3 ettari. Qui si produce dal 1576 il vino per la messa del Papa, un bianco ottenuto da uve Malvasia del Lazio. La produzione, di circa 20.000 bottiglie l’anno, è destinata principalmente al consumo interno della Santa Sede, ma una piccola parte viene messa in vendita per beneficenza.
La tutela e il futuro dei vigneti urbani
Questi dieci esempi rappresentano solo una piccola parte del patrimonio di vigneti urbani italiani. Un tesoro che necessita di tutela e valorizzazione. Molti di questi progetti godono già di forme di protezione, come nel caso dei vigneti all’interno di ville storiche o aree monumentali. Altri sono oggetto di specifici piani di salvaguardia da parte delle amministrazioni locali.
Il futuro di questi vigneti passa attraverso una maggiore consapevolezza del loro valore non solo enologico, ma anche storico, culturale e ambientale. Rappresentano infatti un presidio di biodiversità all’interno delle città e un importante strumento di educazione ambientale. Inoltre, la loro presenza contribuisce a migliorare la qualità della vita urbana, creando spazi verdi e produttivi in contesti spesso densamente edificati.
La sfida per il futuro sarà quella di trovare un equilibrio tra preservazione e fruibilità. Visite guidate, degustazioni, eventi culturali: sono molte le iniziative che potrebbero contribuire a far conoscere e apprezzare questi vigneti urbani, trasformandoli in veri e propri ambasciatori del patrimonio vitivinicolo italiano.
In un’epoca in cui il rapporto tra città e campagna si sta ridefinendo, i vigneti urbani rappresentano un ponte ideale tra questi due mondi. Un calice di vino prodotto all’ombra di un campanile o di un palazzo storico non è solo un piacere per il palato, ma un vero e proprio viaggio nella storia e nella cultura italiana. Un viaggio che vale la pena di intraprendere, alla scoperta di questi tesori nascosti nel cuore delle nostre città.

Curioso per natura, vivo la vita come se non ci fosse un domani.